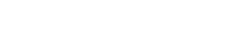Ha preferito i gesti spettacolari alla teologia, l’ideologia secolare alla liturgia. Lascia una Chiesa svuotata nella dottrina, soft power globalista e troppo a suo agio con i nemici degli ebrei
Con Papa Francesco, se n’è andato il pontefice più politico dai tempi dei Borgia. Jorge Mario Bergoglio, un uomo che ha preferito i gesti spettacolari alla teologia riflessiva, l’ideologia secolare alla liturgia sacra, lascia una Chiesa svuotata nella dottrina, distratta dall’attivismo sociale e troppo a suo agio in compagnia dei nemici degli ebrei.
Soft power globalista
Sin da quando il cardinale argentino si affacciò dal balcone nel 2013 come “vescovo di Roma”, fu chiaro che il suo pontificato sarebbe stato diverso. Non nel senso di un rinascimento della fede cattolica o di un ritrovato rigore morale, ma nella trasformazione della Chiesa in uno strumento di soft power al servizio delle cause globaliste: massimalismo migratorio, allarmismo climatico e, sciaguratamente, una rinnovata ostilità verso lo Stato ebraico.
La teologia della liberazione
Le radici di Francesco nella teologia della liberazione, nata in America Latina durante le insurrezioni marxiste, non sono mai state marginali. Al contrario, costituivano la base della sua interpretazione del mondo. La sua visione della Chiesa non era primariamente sacramentale o metafisica, ma programmatica: giustizia in terra, più che salvezza in cielo.
I sacerdoti come assistenti sociali, non come pastori d’anime. La fusione gesuitico-peronista che lo ha formato a Buenos Aires ha prodotto un Vaticano che ha cominciato a parlare come il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile e ha smesso di parlare di Dio.
L’ambiguità con Israele e gli ebrei
Ma è il suo atteggiamento verso gli ebrei, e verso Israele, a rappresentare uno degli aspetti più inquietanti del suo lascito. A differenza di Giovanni Paolo II, che pregò al Kotel chiamando gli ebrei “nostri fratelli maggiori”, o di Benedetto XVI, che invocava umiltà teologica nel dialogo con l’ebraismo, Francesco ha spesso ceduto a impulsi più vicini agli istinti oscuri della vecchia curia antigiudaica.
All’inizio, i leader ebraici gli concessero il beneficio del dubbio. Incontrò rabbini, pronunciò parole amichevoli allo Yad Vashem. Poi il tono cambiò – prima in modo sottile, poi plateale. Invitò Mahmoud Abbas in Vaticano e lo definì “un angelo della pace”. Si incontrò con chierici negazionisti della Shoah come Mohammad Hussein, il Gran Muftì dell’Autorità Palestinese. Paragonò Gaza al ghetto di Varsavia. E lo fece mantenendo un’ambiguità studiata che gli permetteva di rifugiarsi dietro banalità interreligiose quando veniva messo in discussione.
Il Papa dell’equidistanza
Francesco è stato il Papa dell’“equidistanza” tra la sofferenza ebraica e il terrorismo palestinese. Dopo il pogrom di Hamas del 7 ottobre 2023, quando neonati furono bruciati vivi e donne stuprate in nome del jihad, Francesco attese giorni prima di parlare. E quando lo fece, invocò la fine della “violenza da entrambe le parti”. Non era il linguaggio di un leader morale. Era il lessico sfuggente e mellifluo di un diplomatico impegnato a non irritare gli alleati ideologici.
Nessun pontefice, dal Concilio Vaticano II in poi, aveva trattato con tanto fastidio il diritto del popolo ebraico all’autodifesa. La Chiesa, sotto Francesco, è tornata a flirtare con quel vecchio sospetto: che la sovranità ebraica sia un problema, e il nazionalismo ebraico un’offesa morale.
Parole e opere
Non si trattava solo di parole. Sotto Francesco, il Vaticano ha rifiutato di riconoscere Gerusalemme come capitale d’Israele, anche dopo che gli Stati Uniti l’avevano fatto. Ha sostenuto risoluzioni Onu che negano i legami ebraici con il Monte del Tempio. La missione vaticana a Gerusalemme si è comportata più da ong anti-sionista di basso profilo che da custode dei luoghi cristiani.
Attribuire questi atteggiamenti ai consiglieri o ai vincoli diplomatici sarebbe comodo. Ma la coerenza del suo comportamento è stata troppo netta. Francesco ha trovato il tempo per ricevere Greta Thunberg ed Emma Bonino, ma non ha mai visitato una sinagoga a Gerusalemme. Ha avuto parole dure per le politiche migratorie di Trump, ma nessuna per le ambizioni nucleari dell’Iran. Ha condannato il capitalismo come “lo sterco del diavolo”, ma non ha mai detto chiaramente che Hamas è il male.
Semplicità e radicalismo
I suoi difensori citano il suo impegno per i poveri, il suo stile mite, la sua umiltà. Ma un uomo può vivere in semplicità e fare comunque molto male. Nella Chiesa di Francesco, la semplicità è diventata una copertura per radicalismo politico ed erosione teologica. L’altare è stato sostituito dal palcoscenico.
La Chiesa dei poveri
Sotto la sua guida, il baricentro del cattolicesimo si è spostato dall’Europa all’America Latina e al Sud globale, non nei numeri – quel processo era già in corso – ma nella tonalità ideologica. La teologia della liberazione, un tempo messa al bando da Roma, è tornata con un nuovo nome: “la Chiesa dei poveri”. Il risultato è stato un Vaticano allineato con movimenti più interessati agli slogan che ai sacramenti, più a suo agio con i risentimenti post-coloniali che con i Dieci Comandamenti.
Francesco non è stato il primo Papa a politicizzare l’altare, ma è stato il più abile a farlo sotto le spoglie dell’umiltà. I sandali, la piccola Fiat, i gesti come lavare i piedi ai migranti maomettani: tutte immagini che nascondevano una regressione più profonda, una Chiesa il cui leader ha perso interesse per le radici ebraiche del cristianesimo e ha iniziato a parlare come un ministro degli esteri latinoamericano dell’epoca di Chávez.
I danni restano
Ora è morto. Ma il danno resta. Gli istinti anti-sionisti che egli ha normalizzato, l’appiattimento della teologia in messaggi sociali, la complicità con la politica radicale, tutto questo sopravviverà. Qualcuno lo ricorderà come il “Papa dei poveri”. Altri come l’uomo che ha reso di nuovo intellettualmente accettabile l’antigiudaismo cattolico.
Bepi Pezzulli – Atlantico